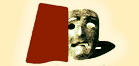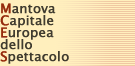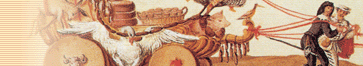|
|
| |
 |
L'ARLECCHINO D'ORO |
|
ARLECCHINO SIGNORE DI DUE REGNI: LA
COMMEDIA DELL'ARTE, E IL TEATRO MODERNO di Roberto Tessari
(Università di Torino)
 |
| Ferruccio
Soleri |
Ferruccio Soleri assume ufficialmente per la prima volta la
maschera e l’abito multicolore di Arlecchino nel 1960, a
Broadway, durante la tournée americana che sancisce il
trionfo internazionale del Servitore di due padroni. Se
restiamo alla superficie della storia, potremmo anche ascrivere
il fatto a mere necessità contingenti: la legislazione teatrale
degli Stati Uniti, infatti, prevede che l’attore principale di
qualsiasi compagnia venga rimpiazzato nel ruolo – una volta la
settimana – dal suo sostituto, e anche il prestigioso ensemble
guidato da Strehler dovette allora prestare ossequio a questa
regola. Ma, a ben vedere, ogni autentica ‘occasione’ nasce -
in arte - solo sul terreno del più rigoroso e duro tirocinio:
come quello, appunto, che aveva portato il giovane Soleri
(entrato a far parte della fortunatissima produzione del Piccolo
nel 1959, per figurarvi come “un cameriere che non parla”) a
essere individuato quale allievo d’elezione da Marcello
Moretti, che lo iniziò allo studio sistematico della maschera,
e che – già prima di Broadway – lo aveva messo alla prova
come proprio ‘sostituto’ in alcune repliche dello
spettacolo. Del resto, un’occasione tanto preparata può anche
assumere l’aspetto d’un destino, ove si pensi che Moretti,
pochi anni prima, era stato spettatore alla prova generale di
quel saggio degli allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica
romana (La figlia obbediente di Goldoni) dove Soleri,
pervenuto al terzo anno di corso, figurava proprio nei panni di
Arlecchino: essendosi deciso a indossarli, dopo non scarse né
poco motivate resistenze, per le pressioni del suo maestro
Orazio Costa…
Un Arlecchino predestinato e insieme riluttante, dunque. E non
solo in quanto estremamente consapevole delle barriere culturali
e linguistiche tra la propria toscanità e l’irriducibile
dimensione della Venezia goldoniana (fu Gastone Moschin, per La
figlia obbediente, a confortarne l’approccio all’idioma
lagunare), bensì soprattutto perché saldamente ancorato a una
prospettiva di attorialità affatto moderna: ovvero quantomai
remota – sia a livello di concezioni compositive della
messinscena, sia sul piano dei rapporti tra interprete e
personaggio – da quelle che avevano distinto la lunga storia
dei comici dell’Arte e dei loro epigoni. Non a caso Ferruccio
Soleri, dopo essersi formato all’Accademia, recita sino al
1963 - al Teatro del Convegno di Enzo Guerrieri e al Piccolo –
in un repertorio novecentesco il cui respiro si apre tra la
pirandelliana Favola del figlio cambiato (1956), lo
steinbeckiano Uomini e topi (1959) e L’anitra
selvatica di Ibsen (1962). Né sarà un caso se, pur non
cessando di dar vita a personaggi della drammaturgia classica e
di quella contemporanea, intraprende, a partire dal 1972,
un’attività registica costellata di prove significative vuoi
nell’ambito della prosa (tra le altre: Re Corvo di
Gozzi; La locandiera, I due gemelli veneziani, La
castalda e Il ventaglio di Goldoni; La Mandragora
di Machiavelli) vuoi nel settore dell’opera lirica (Don
Pasquale di Donizetti; Il Barbiere di Siviglia, L’Italiana
in Algeri, Il signor Bruschino, Il Turco in Italia
di Rossini; La traviata di Verdi; Duello comico
di Paisiello; Livietta e Tracollo di Pergolesi; Il
ratto del serraglio e La finta giardiniera di Mozart;
Notte a Venezia di Strauss; La vedova allegra di
Lehar; ecc.).
Sarebbe, insomma, perlomeno fuorviante non voler vedere come,
sotto la maschera di Arlecchino – qui – si celi il volto
d’un attore pronto anche ad assumere, per non citare che un
esempio, il sembiante di Puck nel Sogno d’una notte di
mezza estate, e di un regista impegnatosi a rivisitare
criticamente i percorsi della commedia italiana tra Cinque e
Settecento (nonché a confrontarsi, tra l’altro, con le
complesse grazie musicali dei grandi maestri settecenteschi e
ottocenteschi dell’opera buffa e del melodramma). Non si
tratta di uno sfondo, ma di un contesto. Ed è, appunto, entro
un simile contesto che va collocato l’incontro ‘fatale’
tra Soleri e l’icona-emblema dell’antica Commedia
dell’Arte. Marcello Moretti muore nel 1961. Il 10 luglio 1963
– nel Teatro di Villa Litta ad Affori – la ripresa del Servitore
di due padroni voluta da Strehler ha per protagonista colui
che un tempo ne era stato il ‘cameriere silenzioso’. Come
nel vecchio microcosmo dei comici, un Arlecchino affida
idealmente il testimone dell’eterna staffetta a un altro
Arlecchino: quello che lui stesso ha contribuito ad individuare,
e ad iniziare ai segreti artigianali della parte. Da quel
giorno, Ferruccio Soleri viene unanimemente riconosciuto non già
in quanto ‘sostituto’ elettivo dell’indimenticabile
Moretti, bensì quale individualissimo ri-creatore della
maschera. E’, ancora una volta, il rinnovarsi del mito: più
di duemila repliche in Italia e nel mondo, sino all’ultima
edizione – la nona! - curata da Strehler nel 1997.
Soleri stesso, in una intervista del 1991, ricorda come – al
tempo del suo apprendistato – Moretti si rifiutasse
pervicacemente di svelargli i ‘trucchi del mestiere’ da lui
adottati, nel Servitore, per la famosa ‘scena del
baule’: un lazzo che vede Arlecchino emergere a sorpresa
travestito da una cesta chiusa. Il maestro non desiderava
dall’allievo una copia: voleva spingerlo a ricreare da sé,
originalmente, quella gag. Aveva di certo intuito che la
sostanza mercuriale del giovane Soleri (l’agilità acrobatica
e il senso musicale del ritmo, a lui derivati da una intensa
attività sportiva) costituiva la materia prima indispensabile
ad animare di vita nuova le qualità di fondo d’un Arlecchino.
Ma, forse, ancora non poteva sapere come il formatore della
nuova maschera avrebbe saputo contemperare quella ‘sostanza’
con una dote in apparenza contraddittoria: la meditabonda
consapevolezza storico-critica tipica d’un attore moderno,
attento ad approfondire anche (se non soprattutto) lo studio dei
documenti relativi alle più minute teknai escogitate dai
suoi predecessori prossimi e remoti per sostenere la parte.
In effetti, se il testo di Goldoni rielaborato e allestito da
Strehler a partire dal 1947 può essere considerato, tra
l’altro, il miglior contributo italiano a quella riscoperta
internazionale della Commedia dell’Arte che (attraverso Craig,
Mejerhol’d, Vachtangov, Copeau, ecc.) ha inteso restituire al
teatro del Novecento tutta la forza espressiva d’una scenicità
di alta convenzione simbologica, Soleri ha lasciato un
indelebile segno forte sulle lunghe e fortunate vicende del Servitore
di due padroni, ripercorrendo e rivivendo da par suo – sul
versante del lavoro d’attore – le ragioni essenziali e le
finalità ultime che avevano guidato il regista nel suo percorso
di attraversamento critico della perduta dimensione dei
recitanti all’improvviso. Il nuovo Arlecchino è cresciuto nel
tempo: ognora supportato, sì, dall’incredibile verve
fisica e dal tagliente-scontroso garbo ironico del suo
interprete, ma anche rimeditato senza posa – attraverso un
inesausto processo d’alternanza tra piena partecipazione e
rigoroso distacco - da una coscienza riflessa sempre impegnata
nella ricerca e nello studio delle fonti documentarie,
iconografiche e letterarie atte a testimoniare concretamente
sulle mutazioni subite dalla maschera nel corso del tempo, sulle
teknai adottate dai suoi interpreti successivi per
attribuirle voce e movimento, sugli stilemi mimici escogitati e
fissati onde formulare la sua paratassi corporea.
E’ appunto attraverso un simile studio (mai disgiungibile,
come dovrebbe risultare ovvio, dal suo sofferto tradursi in
prassi performativa) che Soleri è pervenuto a qualificarsi
ancora come altissimo esperto delle convenzioni rappresentative
dei comici dell’Arte. E, qui, occorre far menzione non solo
dei moltissimi laboratori da lui guidati in Italia e nel mondo,
ma soprattutto della sua attività di pedagogo presso le più
importanti scuole di teatro internazionali: da quella del
Piccolo milanese alla Otto Falckenberg Schule di Monaco di
Baviera; dalla Mudra belga di Béjart alla Santa Clara
University statunitense, al viennese Max Reinhardt Seminar. Né
andrebbero dimenticate, continuando a considerar le cose da
questa prospettiva, le fortunate prove offerte dall’attore in
qualità di dramaturg d’un rimeditato repertorio ‘arlecchinesco’:
Arlecchino, l’amore e la fame (collage di testi
composto in collaborazione con Luigi Ferrante nel 1969); Arlecchino
e gli altri (scritto in collaborazione con Luigi Lunari nel
1980); Ritratti della commedia dell’arte (1995).
Arlecchino signore della scena. Arlecchino regista. Arlecchino
studioso di materiali d’archivio. Arlecchino maestro di
teatro. Arlecchino autore… Soleri, pur evitando con tacita
ritrosia di far coincidere a pieno il suo profilo di
uomo-artista con quello della mitica icona popolaresca del
secondo Zanni dall’abito fatto a “recamo di concertate
pezzette”, ha traghettato l’antica maschera un tempo
trasferita sulle scene dal genio di Tristano Martinelli oltre le
Colonne d’Ercole del Duemila, dopo averla riplasmata e
illustrata negli ultimi quattro decenni del Novecento. Ha
immesso nella sua silhouette tutte le competenze
specialistiche d’un grande attore italiano nato e vissuto nel
teatro di regia, e dotato d’una consapevolezza critica e
d’una visione estetica superlativamente adeguate all’altezza
dei tempi. Ha studiato le tracce residue del suo passato, per
ridefinirne i contorni attraverso tutti quei contributi che solo
da diverse angolazioni prospettiche potevano essere recuperati.
Ma non lo ha, di certo, fatto a freddo: come i migliori tra gli
antichi comici, si è servito dei risultati delle proprie
ricerche – non diversamente da quanto ha sempre fatto con
l’allenamento fisico, e con gli esercizi di concentrazione e
di meditazione che hanno costituito e costituiscono la ‘faccia
nascosta’ delle sue performances – fondendoli quali
materiali della più rigorosa e difficile alchimia sul crogiolo
scaldato dal fuoco di un quid misterico: il corpo
materialmente mercuriale e l’anima fantasticamente corporale
d’un Arlecchino per grazia e vocazione.
|
|
 Edizioni
de L'Arlecchino d'Oro Edizioni
de L'Arlecchino d'Oro |
|
2005:
Presentazione,
Spettacoli,
Approfondimenti |
|
|
2004:
Presentazione, Premio,
Spettacoli |
2003:
Presentazione, Premio,
Spettacoli, Stampa |
|
2002: Contributo |
2001: Presentazione,
Premio,
Spettacoli,
Stampa |
|
2000: Presentazione,
Premio,
Spettacoli |
1999: Presentazione,
Premio,
Spettacoli |
|
| [ | ] |
Internet partner: Omega-Net [] |
[ ] |
x
Questo sito web utilizza i cookie. Maggiori informazioni sui cookie sono disponibili a questo link. Continuando ad utilizzare questo sito si acconsente all'utilizzo dei cookie durante la navigazione.
|
|
|
|